Sicilia 1943, guerra
e desiderio di pace
Cultura | 9 maggio 2025
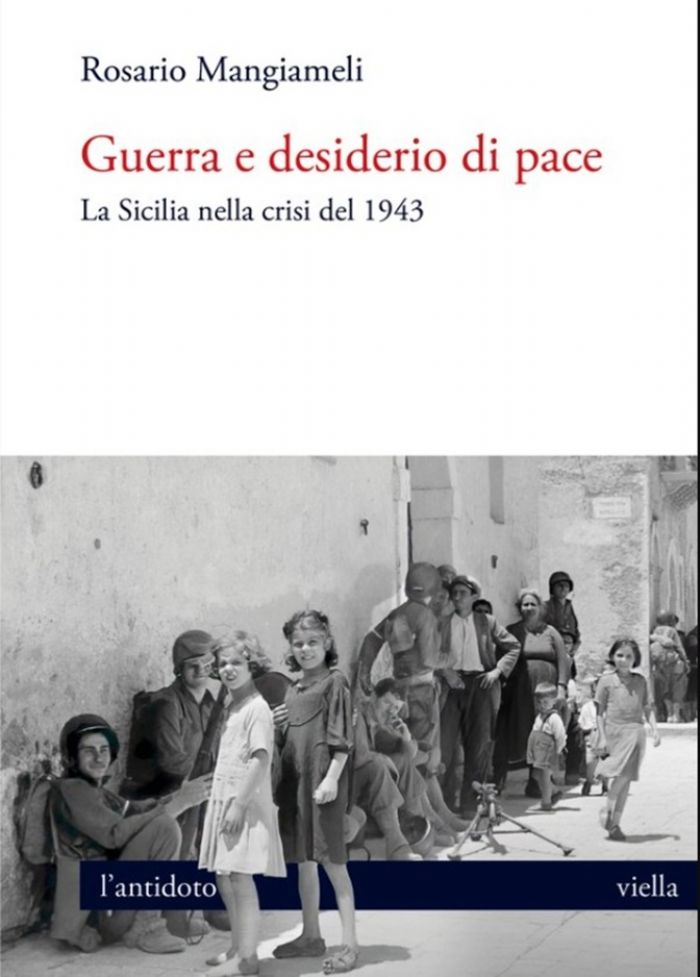
“Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943”, la più recente opera di Rosario Mangiameli (studioso formatosi all’Università di Catania nella quale è stato a lungo professore ordinario di Storia contemporanea) è inserita, non a caso, nella collana L’antidoto che si propone di ospitare libri “che intendono decostruire e confutare interpretazioni e narrazioni prive di credibilità scientifica, ma che ormai fanno parte dell'immaginario pubblico e storiografico”. Compito al quale l’autore certamente non si sottrae. Il libro è il momento di sintesi e rielaborazione di anni di studi e ricerche e costituisce punto di riferimento prezioso per chiunque voglia conoscere e affrontare i nodi decisivi e complessi della storia della Sicilia nell'ultimo secolo.
Articolato su quattro ampi capitoli (“Al centro dell’Impero”, “Quando entrarono gli inglesi”, “O kalós Thanatos. La memoria epica della battaglia di Gela” e “Violenze”) l’opera non si limita alla descrizione degli accadimenti politici e militari, ma indaga in profondità la situazione economica e sociale dell'isola, i suoi contraddittori rapporti col fascismo, i sentimenti e le tensioni che attraversarono la società dell’isola nel momento in cui si trovò tragicamente investita dal conflitto bellico.
Proclamata “al centro dell’Impero” da Mussolini, nel corso della sua visita nel 1937, la Sicilia appariva all'inizio della guerra una regione arretrata dotata di un debolissimo sistema produttivo che non riusciva a fornire le risorse necessarie al proprio fabbisogno alimentare. L’ingresso nel conflitto coincise con l’avvio del cosiddetto assalto al latifondo, ossia la legge del 1 gennaio 1940 sulla “colonizzazione del latifondo siciliano”. Com’è noto, la legge fu poco o punto applicata; in particolare ebbe scarso successo il progetto di appoderamento “per la difficoltà di trovare le risorse necessarie per la costruzione dei borghi rurali”. Tuttavia l’isola assunse una collocazione quasi di prima linea per la sua la sua centralità nel fronte mediterraneo nel quale era principalmente impegnata l’Italia, Appena la guerra cominciò a mordere con i bombardamenti aerei, le criticità si moltiplicarono: scarsa produzione, scarsità di generi alimentari, mercato nero, malfunzionamento degli ammassi si vennero a sommare al collasso dei trasporti provenienti dal Continente ormai divenuti essenziali per sopperire all’assenza di quelli locali e alla crescente sfiducia in una positiva conclusione del conflitto.
Quando nei primi mesi del 1943 i bombardamenti anglo-americani si intensificarono, si determinò una sorta di collasso dell’intero sistema socio-economico. Mangiameli cita i rapporti dei questori degli ultimi mesi precedenti lo sbarco che “descrivono uno spirito pubblico ormai fiaccato dai continui bombardamenti e dalla fame endemica”. A ciò va aggiunto che la maggioranza dei componenti delle forze armate presenti nell'isola, specialmente nei reparti della Milizia volontaria fascista (Mvsn), erano di origine siciliana. Nota l’autore che perciò le risorse dei militari “ormai le poche reperibili divennero importanti per la popolazione civile: se ne fece infatti commercio illegale, ma soprattutto divennero fruibili in virtù del fatto che la maggioranza degli ufficiali e dei soldati in servizio erano siciliani”. Inoltre i rapporti tra i livelli locali e centrali delle pubbliche amministrazioni si erano guastati dopo il telegramma col quale il 5 agosto del 1941 Mussolini aveva disposto il trasferimento dall’isola di ben 1020 funzionari. Altrettanto difficile da spiegare sembra il famoso proclama Roatta del maggio 1943 che, per la sua ambigua formulazione, fu interpretato come “il segno di un’ostentata discriminazione tra popolazione ed esercito”.
Sul piano politico-militare l’operazione Husky progettata a Casablanca nel gennaio 1943 appariva come una mossa preventiva rispetto al prevedibile, ma ancora aldilà da venire, collasso del sistema tedesco nel Mediterraneo. La Sicilia fu l’obiettivo preferito anche per la maggior facilità - rispetto alla Sardegna - di procedere verso il Continente. Le Forze armate italiane schieravano nell’isola 315.000 uomini, oltre al contingente militare tedesco di 90mila soldati. La dotazione di carri armati comprendeva 165 mezzi tedeschi e 100 italiani. I cannoni erano 500. Ben poco invece era rimasto dell’aviazione dislocata nei tanti campi di aviazione che costellavano il territorio, sostanzialmente resa inoffensiva dalle incursioni aeree a tappeto. Il giudizio generale era che si trattasse in maggioranza di truppe poco efficienti e che non si erano confrontate con combattimenti di rilievo. Nella notte tra il 9 e il 10 luglio davanti alle coste meridionali della Sicilia si presentarono una flotta di 2775 navi da trasporto e da guerra e una forza da sbarco costituita da 115mila britannici e 66mila americani, dotata di cannoni e mezzi corazzati in numero e qualità assai superiore rispetto alle forze dell’Asse. Gli anglo-americani sarebbero diventati circa mezzo milione a metà agosto, quando la battaglia di Sicilia si concluse.
L’esito negativo della battaglia per la Sicilia nel luglio/agosto del 1943 segnò la sconfitta militare dell’Italia e la fine del fascismo. Il collasso sui campi di battaglia condusse ben presto alla frana generalizzata delle istituzioni civili e militari, a partire dalle strutture locali del Pnf in preda alla confusione e al panico dopo la notte del Gran Consiglio del 25 luglio che portò alla destituzione di Mussolini. L’armistizio di Cassibile annunciato l’8 settembre e la fuga del sovrano da Roma portarono alla dissoluzione di quanto restava del Regio Esercito. La sconfitta nell’isola fu insomma prodromo alla sconfitta definitiva e all’aprirsi del periodo drammatico che avrebbe portato alla divisione del paese, alla Rsi (Repubblica sociale di Salò in mano agli estremisti del fascismo repubblicano), alla Resistenza. Tuttavia la campagna di Sicilia fu per le truppe alleate tutt’altro che una passeggiata. Essa fu lunga e sanguinosa e dette luogo a scontri militari feroci, come la battaglia di Gela, con il sacrificio della Divisione Livorno e l’assedio di Catania, mentre le truppe americane - nelle cui file era proporzionalmente notevole la presenza di siculo-americani - al comando del generale George S. Patton, che riuscirono ad arrivare a Palermo il 22 luglio, affrontarono anch’esse scontri assai duri.
Opportunamente Mangiameli fa notare che l’operazione Husky ebbe durata assai più lunga della conquista tedesca della Francia nella primavera del 1940. La differenza delle forze che si fronteggiavano, la situazione generale delle truppe dell’Asse, le condizioni di sfascio economico e sociale, la crisi incombente del regime, spiegano a sufficienza lo svolgimento reale degli avvenimenti e consentono di rintuzzare le numerose versioni complottistiche messe in campo nel corso degli anni: dal supposto tradimento degli ammiragli e dei generali, che fu argomento prediletto della polemica della destra nell’immediato dopoguerra, alla versione, diffusa nel dibattito pubblico siciliano per molti anni, secondo cui sarebbe stata la mafia a “favorire lo sbarco ed orientare le politiche di occupazione fino a condizionare in modo permanente il quadro politico regionale e nazionale”.
Il capitolo “Violenze” è dedicato ai comportamenti “stragisti ai danni della popolazione civile e di alcuni militari” di cui si resero responsabili sia le truppe anglo-americane che quelle tedesche. Mangiameli segnala come l’affermazione dell’attitudine stragista delle truppe americane, in particolare in riferimento all’eccidio avvenuto all’aeroporto di Biscari, sia venuta anche da fonti statunitensi e costituisca l’occasione per tentare un lettura più approfondita degli atteggiamenti delle truppe combattenti e dei rispettivi comandi. Mentre da parte americana si celebrarono, ancora nel corso del conflitto, processi contro i colpevoli, da parte tedesca non ci fu alcuna sanzione da parte dei superiori, anzi le atrocità furono in qualche modo legate al peggioramento dei rapporti tra italiani e tedeschi, anche al livello delle gerarchie militari, verificatosi dopo la caduta del fascismo.
La sollevazione popolare di Mascalucia contro le violenze delle truppe tedesche del 3 agosto che costò 14 vittime, l’assalto all’Eremo di Valverde, la vicenda di Castiglione di Sicilia del 12 agosto dove si contarono 16 civili uccisi, 20 feriti e due o trecento persone tenute in ostaggio per due giorni - a volte considerate una sorta di forma di proto-resistenza - sono giudicate correttamente dall’autore “di difficile lettura... segno evidente della difficoltà a trovare un orizzonte nel quale quelle vicende potessero acquistare significato”.
Da segnalare il paragrafo dedicato alla violenza sulle donne: il timore di subire violenza è generato dalla situazione di insicurezza generale. Anche nell’isola si verificò il dramma delle donne violentate dalle truppe marocchine del IV Tabor inquadrate nell’Armata statunitense, di cui ben più ampia memoria sarebbe rimasta nelle vicende dell’avanzata degli Alleati nell’Italia centro-meridionale, come ci ricorda, per esempio, il romanzo “La Ciociara” di Alberto Moravia. Infine i complessi problemi dell’immediato dopoguerra e del governo militare alleato della Sicilia, che sarebbe stata riconsegnata al Regno d’Italia solo nel febbraio 1944: il lento e faticoso riavviarsi della vita democratica, innanzitutto delle organizzazioni sindacali e poi dei partiti, la benevola accoglienza che la popolazione riservò alle truppe occupanti e che facilitò il compito iniziale dell’Amgot, la notevole autonomia di cui godevano i Cao (Civil Affairs Officers) nell’amministrazione locale, le contraddizioni nell’opera di epurazione degli apparati fascisti.
In generale l’amministrazione alleata si trovò a fare i conti con istituzioni che sembravano essersi dissolte e con una società civile dominata dall’incubo della fame e dall’incertezza del futuro. La presenza mafiosa fu subito avvertita: l’autore ricorda che alla fine di ottobre 1943 le alte sfere militari alleate ebbero i risultati dell’inchiesta commissionata al capitano statunitense William E. Scotten, che era stato viceconsole a Palermo. “The problem of mafia in Sicily”, che Mangiameli aveva già studiato e pubblicato nel 1981, individua la pericolosità della mafia di cui Scotten intuì subito il ruolo politico. Ruolo che si esplicitava innanzitutto nel rapporto col separatismo che la mafia assunse come proprio orizzonte politico. “Attorno al Mis (Movimento indipendenza siciliana) si ricostituì quella solidarietà piramidale, che andava dal grande possidente al piccolo proprietario, saldata dall’opposizione agli ammassi granari”. Qui si apre il sanguinoso dopoguerra siciliano. Tra i primi episodi di ciò che si caratterizzerà con un lungo conflitto tra le masse del mondo contadino e bracciantile che lottava per l'applicazione dei decreti Gullo e le forze che si opponevano in nome della conservazione e della reazione sociale - delle quali la mafia fu braccio armato - lo storico catanese individua la tentata strage di Villalba del 16 settembre del 1944 con la quale il capomafia Calogero Vizzini tentò di impedire il comizio del leader comunista Girolamo Li Causi. “La mafia restò un attore stabile del conflitto sociale di quegli anni a cui si oppose una sempre più compatta risposta democratica e popolare.”
^^^^^^^
Rosario Mangiameli: Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943 (Viella 2025, pagine 277, euro 26,00)
Ultimi articoli
 Il voto di fiducia come strumento di inganno
Il voto di fiducia come strumento di inganno  Il grido dell’impegno civile alla marcia antimafia
Il grido dell’impegno civile alla marcia antimafia  La marcia antimafia sulla "strada della vita"
La marcia antimafia sulla "strada della vita"  Addio a Ignazio Gaudiano con la Torre fu compagno di lotta per le terre
Addio a Ignazio Gaudiano con la Torre fu compagno di lotta per le terre  Anticorruzione debole, poteri criminali più forti
Anticorruzione debole, poteri criminali più forti  La Sicilia e i “frammenti”
La Sicilia e i “frammenti”
di storie controverse,
la lettura di Garufi La Torre e Terranova diedero 50 anni fa un volto a Cosa nostra
La Torre e Terranova diedero 50 anni fa un volto a Cosa nostra  Il mondo senza regole nemico dell’Europa
Il mondo senza regole nemico dell’Europa  Marcia antimafia, da Bagheria un appello: “Liberi dalla paura”
Marcia antimafia, da Bagheria un appello: “Liberi dalla paura”  Mafia e politica, 50 anni fa la relazione di minoranza voluta da La Torre
Mafia e politica, 50 anni fa la relazione di minoranza voluta da La Torre