Libertà e creatività contro tradizione e avanguardia
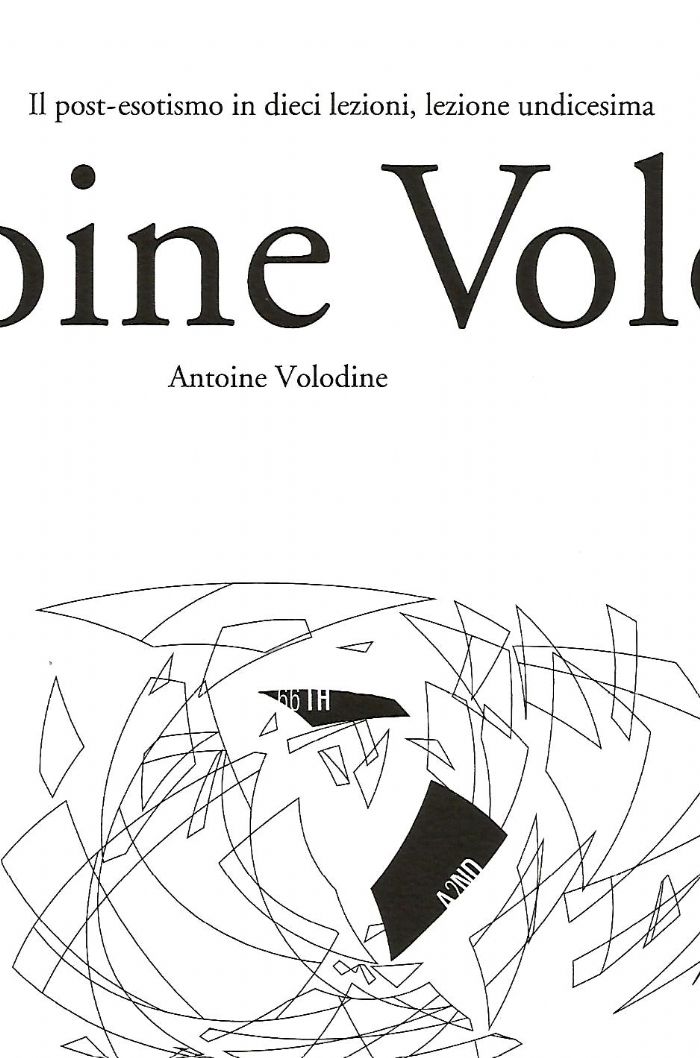
Dedicato a chi ha amato – di un amore complesso ma appagante – “Terminus radioso”. O a chi non ha idea di cosa sia, ma è curioso, è vuol provare a immergersi in un testo inclassificabile, visionario e fiabesco, che brulica di allegorie e virtuosismi, ambientato in una seconda Unione Sovietica. La perfetta introduzione a questo “romanzo” (termine riduttivo, perché troppo circoscritto) e a gran parte della produzione del francese Antoine Volodine, o comunque la chiave per aprire il suo mondo sterminato, è “Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima” (112 pagine, 16 euro), pubblicato e tradotto, come l’enigmatico e affascinante “Terminus radioso”, rispettivamente dall’editore 66thand2nd e da Anna D’Elia, a quasi vent’anni dalla sua comparsa in patria.
Prima cosa: come anche in “Terminus radioso”, Volodine si diverte parecchio. Il gioco è comunque… serio. Con “Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima” Volodine scrive un saggio che vuol sembrare un oggetto narrativo, attraverso i suoi personaggi disserta su generi diversi (lezioni, intrarcane, Romånso, Shaggås), elenca autori e libri, addirittura un’intera bibliografia della letteratura post-esotica, compresi volumi suoi, o pubblicati sotto pseudonimi, e altri che … non esistono. È il manifesto programmatico di un progetto letterario, di un movimento artistico che tecnicamente non esiste se non in questo autore francese di origine russa e nei suoi eteronimi (coi quali peraltro ha pubblicato). Ma cos’è, in definitiva, il post-esotismo? Tutto ciò che è oltre il moderno e il post-moderno, che non è tradizione e non è assimilabile all’avanguardia anche se talvolta a essa è accostata, che giunge da luoghi imprecisati e lontani ed è un mistero poco decifrabile («Il post-esotismo è una letteratura che proviene dall'altrove e incede verso l'altrove»). Nessun francese è così poco francese come Volodine, che ha visione, teoria e pratica letteraria globale e inscena una esile fiction sulle voci – raccolte da raccolte da Niuki e Bloto, giornalisti legati al potere e ai servizi segreti – di alcuni scrittori, gli ultimi post-esotici, reclusi nel carcere di massima sicurezza di una terra devastata da una catastrofe. Loro (improbabilmente battezzati Lutz Bassmann, Ellen Dawkes, Erdogan Mayayo, Ingrid Vogel, solo per citarne alcuni) sono i reduci di una battaglia «egualitarista», portata avanti fin dagli anni Settanta, contro l’«universo capitalista e le sue innumerevoli ignominie», caduti sul campo e alla sbarra. Una ribellione non solo sociale, la loro, ma principalmente letteraria, una rivendicazione artistica apolide, di creatività e libertà, a trecentosessanta gradi.
Ultimi articoli
 Progetto educativo: solitudine e disagio spingono alla droga
Progetto educativo: solitudine e disagio spingono alla droga  Nigrelli, l’intellettuale
Nigrelli, l’intellettuale
che amava l’ambiente
e aveva scelto la provincia Droga e mafia, confronto al Progetto educativo
Droga e mafia, confronto al Progetto educativo  A cosa mira il nuovo “poliziotto del mondo”
A cosa mira il nuovo “poliziotto del mondo”  A cosa mira il nuovo “poliziotto del mondo”
A cosa mira il nuovo “poliziotto del mondo”  Appello antiracket,
Appello antiracket,
una carta etica di valori I ragazzi discutono della marcia antimafia
I ragazzi discutono della marcia antimafia  I destini diversi
I destini diversi
in via Arenella Le nuove mafie attori della finanza e dei mercati
Le nuove mafie attori della finanza e dei mercati  La nuova bussola
La nuova bussola
politica americana